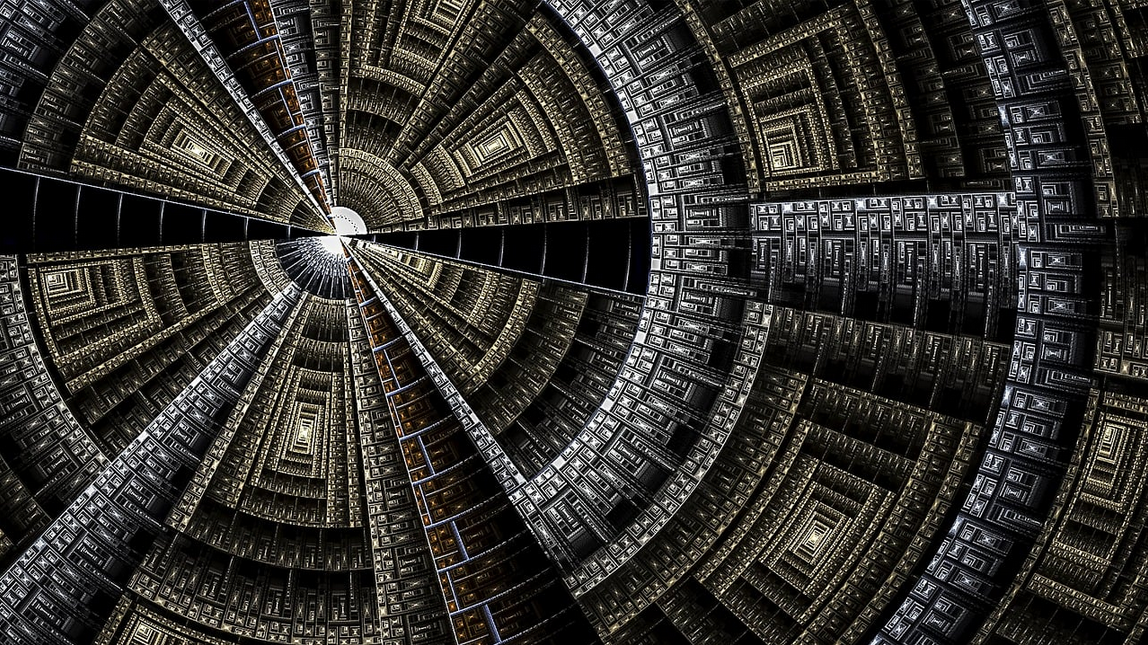di Luigi Sposato
Relazione tenuta il 20 aprile 2023 presso la Biblioteca del Liceo Classico di Cosenza, nell’ambito del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura Citta di Palmi. On The Road. Viene pubblicata su gentile concessione dell’autore, con la precisazione che le opinioni e le valutazioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Sommario
- L’elefante rosa
- Cosa diremo oggi
- ‘Noi’
- Limitare quel ‘noi’
- L’invenzione del diritto
- Il racconto costituzionale
- Bibliografia (minima) ragionata
L’elefante rosa
Prima di iniziare devo imporvi un divieto: non dovete assolutamente pensare a un elefante rosa.
…A cosa state pensando? A un elefante rosa, giusto?
Questo esperimento ci consente di trarre alcune considerazioni che torneranno utili nel prosieguo del nostro discorso.
1) Siamo capaci di elaborare un pensiero astratto: possiamo pensare sia a cose che non sono qui (elefante) sia a cose che non esistono (elefante rosa).
2) Il nostro cervello opera in positivo: non possiamo non pensare a qualcosa; e, in genere, lo fa in forma narrativa; il vostro elefante rosa stava, di certo, facendo qualcosa. Lo avete immaginato mentre compiva un’azione.
3) Le parole generano un effetto. Si dice che contano i fatti non le parole, ma le parole sono un fatto. Pensate all’enunciato “lo giuro”. Nel momento in cui qualcuno lo pronuncia, quel qualcuno sta facendo proprio quella cosa (quel fatto) che è giurare.
Adesso cominciamo.
Cosa diremo oggi
Ci sono due temi che ci interessano, e l’uno fa da sfondo all’altro. Ci interessa parlare di democrazia e ci interessa capire che senso ha individuare come sfondo del nostro discorso l’endiadi “diritto e letteratura”. Un’endiadi esprime un concetto unico per mezzo di due parole.
In prima approssimazione, possiamo dire che “diritto e letteratura” è un certo modo di studiare il diritto; ossia di approcciare il fenomeno giuridico. Per capire in cosa consiste questo metodo, questo approccio, ricorreremo a una definizione ‘ostensiva’. Una definizione ‘ostensiva’ è una definizione che consiste nel mostrare ciò che deve essere definito. Alla fine del nostro incontro, dunque, voi saprete che quello abbiamo detto e fatto oggi è “diritto e letteratura” (o meglio è una parte: alcune componenti di questo metodo e di questo approccio, difatti riusciremo solo a sfiorarle).
Una delle cose di cui si occupa “diritto e letteratura”, ma che ci limiteremo a sfiorare, è l’approfondimento delle tecniche di elaborazione dei discorsi giuridici. I discorsi giuridici sono discorsi argomentativi con i quali l’oratore intende persuadere della bontà della propria tesi un uditorio (che in genere è composto da soggetti che saranno chiamati a esprimere un giudizio di adesione o meno alle tesi dell’oratore). Le tecniche di composizione e la struttura stessa del discorso sono adattamenti in chiave moderna delle tecniche retoriche e della struttura delle orazioni che sono oggetto dei vostri studi.
In un certo senso, la retorica classica è la prima forma di manualistica processuale. La retorica nasce a Siracusa nel V secolo a.C. quando, con la caduta della tirannide, si celebrano una serie di processi per la rivendicazione delle terre che erano state espropriate dai tiranni per essere date come premio ai militari. La pratica di questi processi conduce alla sistemazione di una serie di tecniche di elaborazione dei discorsi e alla creazione di una nuova figura professionale che è il logografo: letteralmente l’autore del discorso. I Logografi sono gli antesignani degli avvocati: scrivono i discorsi che le parti terranno di fronte ai tribunali proprio perché vige il divieto di difesa tecnica: ciascuno deve presentarsi personalmente davanti ai giudici.
La composizione del discorso giuridico non è lontana dalla composizione di altre tipologie di discorsi che hanno pur sempre una funzione persuasiva. A esempio, i discorsi di carattere politico o di carattere celebrativo nel cui novero troviamo il discorso da cui partiremo: il discorso che il Presidente Lincoln tenne a Gettysburg nel 1863.
In chiusura parleremo di un altro discorso: che non è quello di Pericle, che voi di certo conoscete. Discorso celeberrimo, che ci arriva attraverso l’opera di Tucidite e che ha qualcosa in comune con quello di Lincoln, come vedremo. Chiuderemo il nostro incontro con un discorso meno noto al grande pubblico, ma più importante per la nostra storia e per la nostra democrazia. Mi riferisco all’arringa difensiva pronunciata dal Piero Calamandrei durante il processo a Danilo Dolci. Calamandrei e Dolci sono due giganti del novecento italiano; capiremo perché.
Nel mezzo, racconteremo la storia del GGG (Grande Gigante Gentile). È un romanzo per bambini che dice cose interessanti per un giurista. Parlando del mondo dei giganti e del grande gigante gentile, cercheremo di capire cos’è il diritto, e in che modo il diritto serve a mediare tra io e noi (che sono i due poli del nostro titolo).
Per capire cos’è il diritto, quando e come è nato, subito dopo, parleremo del Più grande uomo scimmia del pleistocene (un altro romanzo, scritto d Roy Lewis). Un romanzo in cui l’evoluzione dei Sapiens (la specie di ominidi a cui apparteniamo anche noi) è raccontata come se si fosse la vicenda esistenziale di un solo uomo che scopre tutto quello che a noi è servito per evolverci come specie. In questa parte, vedremo che il diritto e il linguaggio nascono praticamente insieme. E questa è una cosa che ci interessa nell’ottica del nostro metodo che è “diritto e letteratura”.
Il linguaggio non è uno strumento del diritto, ma il diritto è un certo modo di usare il linguaggio, in vista di uno scopo. Insieme al diritto e al linguaggio, nasce un’altra cosa: il lavoro. E anche questo ci torna utile perché nel primo articolo della nostra costituzione il fondamento della repubblica democratica è individuato esattamente nel lavoro. Questa dimensione, ossia la dimensione del lavoro, è presente indirettamente nella stessa etimologia della parola democrazia. La democrazia (quella di Pericle, per intenderci) non è il “regime di tutti” ma è il regime del demos e il demos è una parte della società; quella parte della società che si differenza rispetto ai possidenti. Il tratto caratteristico della democrazia degli ateniesi è l’isonomia: uguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche. Tutti i meritevoli, non solo i possidenti, possono accedere alle cariche pubbliche.
Linguaggio, diritto, lavoro: elementi strutturali della democrazia e componenti della cittadinanza (intendo cittadinanza in senso lato, come appartenenza a una società comune).
Diamo inizio alle danze.
‘Noi’
Immaginate di trovarvi in Pennsylvania il 19 novembre del 1863. La Pennsylvania è sul versante atlantico degli Stati Uniti: a sud ci sono Delaware e la Virginia, a nord c’è New York. Immaginate di trovarvi sulle alture nei pressi di una cittadina che si chiama Gettysburg. Immaginate di vedere un’infinita distesa di sepolture, e di croci bianche infisse nel terreno. Immaginate di vedere, poco più in là, alcuni uomini che montano un palco. I primi giorni di luglio del 1863, due eserciti si sono scontrati proprio qui, e migliaia di persone sono morte. Qui si è svolta la più sanguinosa battaglia della guerra di secessione americana. Tra una manciata di minuti, Abraham Lincoln, il vostro Presidente, salirà su quel palco per commemorare quei morti, per consacrare questo cimitero di guerra. Sentite la commozione per ciò che è accaduto? Percepite l’eccitazione per quello che sta per accadere?
Quello che non potete immaginare, sentire e percepire, però, è che proprio su quel palco, a ridosso di quelle sepolture, Lincoln pronuncerà uno dei discorsi più famosi della storia americana. Un discorso commemorativo, certo, ma anche e soprattutto un discorso politico. Il discorso di Lincoln dura una manciata di minuti; è lungo quanto un foglio A4 con interlinea 1,5. Sono circa 270 parole. È tanto breve che i fotografi non fanno neppure in tempo a immortalarlo. Esistono un paio di foto ufficiali dell’evento; foto in cui si intravede la figura di Lincoln ai piedi del palco, quando ha già finito di parlare.
In quelle poche parole, sul finale del discorso, c’è una meravigliosa definizione della democrazia. Lincoln definisce la democrazia come “un governo del popolo, dal popolo, per il popolo”. Ciò che gli interessa è il racconto della dimensione collettiva che ha condotto la nazione americana fino a lì, fino quel preciso momento. La parola che ritorna più spesso in tutto il discorso è il pronome ‘noi’.
La stessa cosa accade nel discorso che Pericle tiene per commemorare i morti del primo anno della guerra del Peloponneso: un altro discorso commemorativo e politico allo stesso tempo. “Noi ad Atene facciamo così”: Pericle, almeno così ci racconta Tucidite, lo ripete più volte. ‘Noi’ è il primo polo del nostro ragionamento di oggi. Il primo tra i principi costitutivi della democrazia è il principio di sovranità popolare: noi. Noi che siamo il popolo. L’articolo di apertura della nostra costituzione recita: La sovranità appartiene al popolo. Ma la sovranità popolare non basta, e l’articolo 1 della nostra Costituzione dice molte più cose su cui torneremo a breve.
Lincoln sa che vincerà la guerra e sa anche che dovrà ricostruire quel ‘noi’ perché la guerra di secessione ha creato una spaccatura nella nazione americana. Nel richiamo al popolo, che è un ‘noi’ c’è tutta la bellezza della democrazia. Ma c’è anche tutta la sua fragilità. E proprio a questa fragilità è ispirato il titolo del nostro incontro di oggi.
Il titolo è tratto dall’incipit di un romanzo scritto nel 1924 da un autore russo che si chiama Evgenij Ivanovič Zamjatin. Il romanzo si intitola, per l’appunto, Noi. I personaggi non hanno nome ma sono individuati da un codice alfanumerico. Il protagonista romanzo si chiama D-503. Il romanzo inizia in un momento storico, di un futuro imprecisato, in cui lo Stato unico decide di costruire una navicella, chiamata l’Integrale, con la quale viaggiare nello spazio per far conoscere in tutto l’universo la propria esperienza sociale e istituzionale. Questa necessaria opera di diffusione del proprio modello sociale richiede la partecipazione di tutti, e tutti sono invitati a scrivere qualcosa che lasci una traccia del proprio mondo. La voce narrante del romanzo è D-503 che è uno dei costruttori dell’Integrale. D-503 decide di tenere un diario che sarà inserito nella navicella per raccontare ovunque nell’universo la vita ordinata e felice dello Stato unico. Nello Stato unico, le relazioni umane, anche le relazioni d’amore, sono gestite dall’autorità.
Dalle pagine di questo diario, veniamo a sapere che ciascuno, in questa società, vive in funzione del gruppo e, dunque, riveste un ruolo che gli viene attribuito dal gruppo: ciascuno è una sorta di casella predefinita. Le coppie si costituiscono con un sistema di prenotazioni che ha una finalità biologica: l’innamoramento e gli affetti sono alcune delle vecchie sciocchezze dei tempi antichi. La giornata più importante dell’anno è il giorno dell’unanimità in cui tutti, concordemente, confermano la propria fiducia nei confronti del Benefattore. Il Benefattore è il reggente di questo sistema sociale ed è l’unico che non è identificato da un codice ma da una funzione: che è quella di aver fatto e di fare del bene a favore del ‘noi’. L’annullamento dell’individualità, difatti, ha reso felice il popolo. Non dovete pensare a un regime che crea povertà, che rende schiavi nel senso tradizionale del termine. Il regime del Benefattore ha cancellato dalla storia il bisogno: la società descritta è una società del benessere. Ma la moneta di scambio è la libertà di decidere per sé. La felicità è pagata con l’autodeterminazione.
Un’altra cosa interessante di questa società è che ci viene descritta come una società che non conosce emozioni, che è fredda, asettica: che considera l’immaginazione come una malattia mentale. Si tratta, dunque, di una società che ritiene di aver garantito “una felicità matematicamente impeccabile”, controllando la componente emotiva delle persone e disapprovando ogni forma di immaginazione.
Il richiamo alla matematica, non me ne vogliano i docenti e le docenti di questa materia, è funzionale a descrivere un mondo in cui la felicità è identificata con la perdita di tutti quei ‘fronzoli’ che sono gran parte della nostra vita. Non solo: anche per rendere dimostrabile il concetto stesso di felicità; se la felicità è dimostrabile, allora la felicità è un dato preciso e uguale per tutti. Il diario di D-503 diventa, però, il diario di un tentativo di rivoluzione, organizzato da una parte di quel ‘noi’. Questa rivoluzione inizia con una storia di amore e di attrazione tra D-503 e un’altra donna: dico un’altra perché è tale rispetto alla compagna che il sistema ha assegnato a D-503. Questa scossa emotiva insinua in D-503 il dubbio sul tipo di felicità che lo Stato unico offre al suo popolo. Lo Stato unico seda la rivolta ma non ci sono violenze, arresti, uccisioni: niente di quello che ci aspetteremmo.
Il moto rivoluzionario è controllato, da un canto, contrapponendo l’ordinata felicità dello Stato unico al caos dei tempi antichi; e, dall’altro, invitando la popolazione a sottoporsi all’intervento chirurgico che serve a sradicare la fantasia. Il Benefattore non deva fare altro che dire: ehi, noi qui siamo felici! Quegli altri (quelli che vorrebbero sovvertire il nostro Stato) vi stanno proponendo di tornare alla società che c’era un tempo; quella società in cui non c’era nulla di ‘matematico’. Sono come le sirene di Ulisse: volete ancora il disordine? E allora, se non volete tornare al caos dei tempi antichi, sradicate l’immaginazione dalle vostre vite. Quelli non sono libertari, sono malati di mente.
Ma cos’è l’immaginazione? In prima approssimazione, la definirei come la capacità di elaborare pensieri che vanno oltre la logica dimostrativa. Tutti gli appartenenti al ‘noi’ devono liberarsi del fardello dell’immaginazione se vogliono continuare a essere felici, e a esserlo esattamente in quel preciso modo che è identificato, matematicamente, dallo Stato unico.
Questa differenza tra dimostrazioni e immaginazione ha molto a che fare con la democrazia ma anche con il tema che abbiamo detto essere lo sfondo del nostro incontro. Ha molto a che fare con ‘Diritto e Letteratura’. L’immaginazione non è solo una facoltà degli artisti. Non serve solo a dipingere, scrivere poesie, romanzi, disegnare. L’immaginazione serve anche a individuare e a descrivere società alternative, e a individuare e descrivere sistemi giuridici diversi da quello in cui viviamo. L’immaginazione è una facoltà del giurista perché consente al giurista di mettere in discussione le regole del sistema giuridico in cui opera; gli serve per trovare interpretazioni diverse; per costruire le premesse delle sue argomentazioni. La differenza tra dimostrazione e argomentazioni è significativa per ciò che dobbiamo dire.
Tutti i discorsi giuridici sono argomentativi perché sono basati su premesse di ragionamento incerte; le dimostrazioni non lo sono perché sono basate su premesse certe: la matematica è fatta da dimostrazioni. In un mondo in cui la felicità è matematicamente impeccabile non c’è spazio per quella pratica di mediazione che è il diritto. Le premesse delle argomentazioni giuridiche sono opinabili e, dunque, entro certi limiti negoziabili. Gli assiomi posti a base di una dimostrazione non lo sono. C’è una locuzione meravigliosa che serve a dire, in sintesi, tutto questo. La locuzione è “diritto vivente”. È una locuzione creata dalla Corte costituzionale.
Quello che conta nella pratica giuridica è il “diritto vivente”, ossia (dice la nostra giurisprudenza costituzionale) “l’opinione maggioritaria, maturata in dottrina e in giurisprudenza, sul significato normativo di una disposizione”. Il ‘diritto vivente’ è il diritto per come vive nella pratica delle decisioni giurisdizionali. Ed è un’opinione. Cosa vuole dire la Corte costituzionale?
Il legislatore introduce nell’ordinamento una formulazione letterale che è la disposizione; la disposizione (in un’estrema semplificazione) è un enunciato in cui si afferma che una certa cosa si può fare o meno. Il legislatore, però, non è padrone di quell’enunciato (come lo sarebbe nello Stato unico di Noi) perché il significato effettivo di quell’enunciato sarà deciso insieme alla dottrina che studia quell’enunciato, e alla giurisprudenza che di quell’enunciato deve fare applicazione. Alla fine di questo circuito dialettico (di cui fanno parte il legislatore, la dottrina giuridica e la giurisdizione) sapremo qual è la norma: ossia sapremo cosa è permesso o meno.
Ciò che conta è il “diritto che vive”, e il diritto che vive è frutto di una pratica argomentativa. In questa pratica argomentativa sta il concetto di opinione: noi non conosciamo una “felicità matematica” né norme matematicamente certe perché il diritto è una pratica radicata in premesse incerte e negoziabili. Questa è la ragione per la quale il diritto muta nel tempo, anche a parità di enunciato: cambia la norma (che è frutto dell’interpretazione) perché si adatta alle nuove esigenze; veste realtà che prima neanche potevamo immaginare.
Limitare quel ‘noi’
Il Grande Gigante Gentile è il protagonista di un romanzo di Road Dahl. Dahl ci dice che esistono i giganti; non vivono sulla terra ma vivono in una sorta di mondo al di sopra delle nuvole. I giganti sono una specie di ominidi (appartengono grosso modo al nostro genere che è il genere homo). I giganti scendono sulla terra perché si nutrono di esseri umani che loro chiamano ‘popolli’. Sono cacciatori individuali. Il GGG (Grande Gigante Gentile) non mangia i popolli perché, sebbene egli appartenga a un’altra specie, si sente affine a noi umani. Anche lui scende sulla terra ma non per andare a caccia: solo per catturare i nostri sogni.
L’espediente che fa partire la storia è una bambina che rimane sveglia (incuriosita dalle leggende che ha sentito sull’ora delle ombre, quella in cui i giganti scendono sulla terra) e vede il GGG. Il GGG è costretto a portarla con sé perché nessun umano ha mai visto (né deve vedere) un gigante. Il GGG ha paura che la bambina possa parlare di lui agli altri essere umani, e che gli altri esseri umani possano fare del male al suo popolo. La porta con sé, dunque, ma non la mangia; la nasconde per evitare che gli altri la mangino. Non solo, ma fa di tutto per non farsi scoprire perché se gli altri sapessero che nasconde un popollo, ucciderebbero di certo entrambi.
Alla fine, è proprio il GGG che decide di fermare i giganti per evitare che possano mangiare altri umani. Il GGG e la bambina convincono la regina d’Inghilterra a far intervenire l’esercito. GGG somministra alla regina un sogno che lui stesso ha fabbricato e che convince la regina che il mondo dei giganti esiste. L’esercito interviene e gli altri giganti sono portati lontano in un luogo che non possono abbandonare e dal quale non potranno fare male a nessun altro popollo.
Questa storia può essere analizzata giuridicamente; ne possiamo trarre degli elementi di valutazione giuridica. La posizione del GGG ci consente di introdurre un altro elemento della democrazia: la limitazione del potere del noi, in ragione di valori di tutela della persona in sé. Le persone non possono esistere solo in funzione del gruppo e non devono essere eterodeterminate in ragione dei soli obiettivi del gruppo. Il GGG vuole determinarsi da solo, e vuole che ai popolli sia attribuita pari dignità rispetto ai giganti.
Il GGG, da un canto, è il portatore di valori ‘rivoluzionari’ rispetto alla struttura della società in cui vive; e, dall’altro, riconduce quei valori all’esigenza di rispettare la dignità di tutti, giganti inclusi: i giganti, difatti, non sono uccisi ma vengono trasportati in un luogo da cui non potranno fuggire per fare del male ad altri. GGG rivoluziona la sua società in ragione di valori di rispetto dell’individuo. Lotta contro il ‘noi’ a tutela di ogni ‘io’.
La democrazia, definiamola tradizionale, si basa sul principio di sovranità popolare; ma a partire da una certa fase storica, si è capito che questo non basta. Nella democrazia, per come la conosciamo oggi, è confluita un’altra esperienza culturale che è il costituzionalismo. Esistono due concezioni del costituzionalismo che corrispondono anche a due fasi storiche: in una prima fase (e dunque, in una prima concezione) le costituzioni sono patti con il titolare del potere che servono a limitare quello che il titolare del potere può fare. Il primo costituzionalismo (come dottrina politica e giuridica) ha una funzione limitativa e una connotazione classista: si limita il potere sovrano in ragione degli interessi di una classe (sotto questo profilo, il costituzionalismo delle origini diverge dalla democrazia).
C’è una seconda fase, che noi definiamo del costituzionalismo moderno, per la quale le costituzioni non servono solo a limitare il potere ma ne definiscono il fondamento, e individuano i valori cui si ispira quell’ordinamento giuridico. Il costituzionalismo di questa seconda fase nasce in funzione della tutela dei diritti, e si sviluppa nello stesso periodo in cui nasce il romanzo moderno. Nasce il romanzo e nello stesso periodo si consolidano le teorie dei diritti fondamentali: ossia di diritti che appartengono all’essere umano in quanto tale.
A questo proposito, voglio raccontarvi una storia. La casa editrice Viella ha pubblicato un volume, curato da Claudio Povolo, che contiene la riproduzione di un fascicolo processuale degli inizi del 1600. Si tratta di un processo penale che si svolse presso il Consiglio dei Dieci tra il 1605 e il 1607. Il Consiglio dei Dieci (emanazione del gran consiglio, che è una sorta di gabinetto del Doge) era la suprema magistratura veneziana. Il processo inizia con una supplica (una sorta di esposto) della comunità di Orgiano (piccolo villaggio vicino Vicenza) al Collegio dei Savi (uno degli organi di Governo della Repubblica di Venezia, una specie di consiglio dei Ministri). La comunità denuncia una serie infinita di soprusi e violenze perpetrate dal nobile Paolo Orgiano (che è il nobile di riferimento del villaggio).
Il Collegio invita i rettori di Vicenza a intervenire; i fatti sono talmente gravi che il podestà (è uno dei due rettori, l’altro è il capitano e ha funzioni militari) interviene ordinando l’arresto di Paolo Orgiano, lo interroga e poi la vicenda segue l’iter processuale presso il Consiglio dei dieci. Quello che ci interessa, non è tanto la procedura in sé, ma le accuse a Paolo Orgiano; o meglio alcune delle accuse che gli vengono mosse. Questo in sintesi.
Paolo Orgiano esercita il suo dominio incontrastato con atti di violenza e di prepotenza; è protetto da uno zio (temuto e rispettato da tutti); tra le sue vittime c’è una giovane contadina, Fiore, che vive con la madre rimasta vedova; Fiore sta per sposarsi; Paolo cerca di impedirlo; i due giovani riescono a sposarsi lo stesso, e Paolo fa rapire Fiore dai suoi bravi. Stessa cosa capita anche ad altre donne. A proteggere le vittime c’è fra Ludovico Oddi, che lo zio di Paolo riesce ad allontanare dal villaggio convincendo la curia vicentina che il frate aspira all’amore delle fanciulle e non è un benefattore.
Come avrete notato si tratta di una storia molto simile a “I promessi Sposi” di Manzoni. L’intelaiatura narrativa è identica e alcuni personaggi sono evidentemente ispirati ai protagonisti della vicenda di Paolo Orgiano: fra Cristoforo; Lucia e Agnese; i bravi; Paolo stesso è facilmente identificabile in Don Rodrigo. Non abbiamo la prova storica certa che Manzoni abbia avuto accesso al fascicolo processuale, ma c’è un collegamento personale, come rileva il curatore della pubblicazione: Agostino Carli Rubbi amico dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria – il gruppo di intellettuali lombardi che ruota attorno al periodico “Il Caffè” e prima anche all’Accademia dei pugni – per un periodo è uno dei responsabili della conservazione dei fondi archivistici della repubblica veneziana. Non abbiamo la pistola fumante ma questo collegamento, la struttura narrativa, e i personaggi principali costituiscono (come si direbbe con linguaggio tecnico-giuridico) una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.
Se guardiamo al romanzo di Manzoni nella sua pura dinamica narrativa, il lettore vede la rappresentazione di azioni che è possibile percepire ingiuste, di comportamenti giusti e corretti; il lettore vede gli umili oppressi da un potere prepotente. Il diritto e la letteratura si incontrano al massimo dei livelli, nel caso di Manzoni, i cui lettori possono immedesimarsi nelle vite dei più umili. Questo incontro non è casuale e non può essere ridotto alla semplice ispirazione che Manzoni avrebbe tratto da una vicenda reale. Esiste qualcosa di più profondo: il legame tra linguaggio letterario e linguaggio giuridico è molto più stretto di quanto si possa immaginare.
L’obiettivo di Manzoni è la rappresentazione di azioni (la messa in scena di condotte) che sono per il male, e di azioni che sono per il bene. C’è, dunque, una connotazione etica dei personaggi; in Manzoni questa coloritura etica ha una natura anche religiosa: è la rappresentazione della provvidenza che entra nelle nostre vite. Nel fascicolo e nel romanzo abbiamo le stesse condotte, ma sembrerebbero rappresentate con due finalità diverse.
Al di là delle tante possibili interpretazioni, a noi interessa in questo contesto di ragionamento, un aspetto specifico: la letteratura ha il fine di descrivere condotte antisociali; il diritto quello di prescrivere che condotte simili non siano poste in essere. Il diritto prescrive, certo, ma allo stesso tempo non può fare a meno di descrivere, esattamente come farebbe la letteratura, ciò che vieta o ciò che consente. Se ci riflettete, difatti, ogni norma è costituita dal breve racconto di un fatto. Il legame tra narrativa (in specie, romanzo) e diritto è così forte che secondo alcuni studiosi il processo di consolidamento dei diritti dell’uomo (che avviene tra la fine del settecento e l’ottocento) – mi riferisco ai diritti civili e politici, ossia a quei diritti di libertà che sono il portato della rivoluzione borghese – è stato facilitato (se non determinato) dalla nascita del romanzo moderno.
Lynn Hunt che è una studiosa di questo fenomeno ha scritto un bel saggio che si chiama “La forza dell’empatia” in cui sostiene esattamente questo; ossia che tra nascita del romanzo moderno e diritti umani non ci sia solo contemporaneità ma rapporto causale (o concausale). Secondo questa studiosa, la forma del romanzo moderno consente a tutti l’esperienza di immedesimazione nella vita degli altri: anche nella vita di persona diverse da noi per censo, per cultura, per razza. Il romanzo, difatti, ci racconta la storia degli altri e ce le rappresenta come un fatto unico, irripetibile. Questo è un dato di estrema potenza: il romanzo moderno, dalla fine del 1700 in poi, comincia a raccontare la storia di persone qualunque: non la storia di cavalieri, dame e principi (com’è nella tradizione del romanzo cavalleresco).
Alla fine del ‘700 Rousseau (politologo, teorico del contratto sociale) scrive un romanzo intitolato Giulia, o la nuova Eloisa (il riferimento è all’amore impossibile tra il filosofo medievale Abelardo ed Eloisa). Secondo la Hunt questa è la nascita del romanzo moderno, ed è l’inizio della storia dei diritti umani. L’attitudine a ‘entrare’ nella vita dell’altro come se fosse la propria si chiama empatia; esprime un tipo di intelligenza, diversa da quella logico matematica, che i cognitivisti definiscono intelligenza emotiva. Questa è una facoltà sconosciuta al mondo “matematicamente impeccabile” dello Stato unico. Il principio di sovranità popolare e il costituzionalismo sono le due tradizioni culturali che compongono la democrazia contemporanea.
Si tratta di tradizioni culturali che hanno bisogno di tutti quei ‘fronzoli’ che lo Stato unico di Noi ha eliminato dalla storia: hanno bisogno dell’immaginazione e dell’empatia. Senza immaginazione e senza empatia non avremmo la capacità di argomentare (giuridicamente) che è uno strumento essenziale del confronto dialettico che porta all’evoluzione del diritto; e non avremmo il fine ultimo e utile di quell’argomentare che è la persona umana. L’intelligenza emotiva è il tratto che ci consente di entrare in connessione con gli altri ‘io’, e di farlo con una finalità cooperativa. È quello che conduce il GGG a rivoluzionare il ‘noi’ in cui ha sempre vissuto, e di farlo nel rispetto di ogni ‘io’.
Prima abbiamo parlato della locuzione “diritto vivente”. Il diritto vive proprio perché possiamo immaginare felicità alternative. Il frutto dell’unione tra democrazia e costituzionalismo, dunque, non può essere uno “Stato unico” ma può essere solo ciò che definiamo “Stato di diritto”. Ma che cos’è il diritto?
L’invenzione del diritto
Un primo modo di vedere le cose si affida alla cosiddetta concezione verticale del diritto: il diritto è posto da organi collocati al vertice dell’organizzazione sociale (gli Stati); la violazione delle regole giuridiche, dunque, impone ad altri organi dell’organizzazione statuale di applicare una certa sanzione. Questo approccio è espressione del principio di statualità del diritto ed è espresso dal brocardo “ubi civitas, ibi ius”. Questa è la dimensione del diritto in cui ci riconosciamo. A chiunque di noi verrebbe da dire: questo è il diritto; ossia esiste il diritto quando esiste un’autorità che pone una regola e applica sanzioni ai trasgressori.
Fino alla fine del medioevo, al contrario, il diritto era percepito come un sapiente mix di decisioni del potere centrale; di quella che oggi chiameremmo ‘giurisprudenza’; di norme della tradizione (i costumi degli antichi); di prassi; di pareri dei giureconsulti (cioè di quella che per noi è la dottrina). Questa struttura poliforme rimane in vita anche dopo che Giustiniano, intorno al 530 d.C., decise di codificare l’esperienza giuridica precedente. L’obiettivo è perseguito attraverso la redazione di un Codice contenente le leges o costituzioni imperiali; di un Digesto che è una raccolta ordinata dei frammenti delle opere dei giuristi romani; delle Istituzioni (una sorte di manuale); delle Novelle (una raccolta delle nuove costituzioni). Quest’opera complessa è il Corpus Iuris Civili.
Questa poderosa opera confluisce nell’ordinamento giuridico medievale e giunge a noi grazie all’opera dei giuristi che, a seconda delle correnti e delle fasi storiche, ‘glossano’ e poi ‘commentano’ questa fonte considerata di qualità e autorevolezza irraggiungibili. Le due scuole di giuristi, quella dei glossatori e quella dei commentatori, sono in continuità storica: dapprima, i glossatori chiariscono, passo per passo, il significato letterale del testo; successivamente, i commentatori individuano il senso del testo in una breve riscrittura (non ne seguono, dunque, la linearità). L’ordinamento giuridico medievale conosce fenomeni di regolazione centralizzata ma rimane un sistema a pluralità di fonti, con una forte componente consuetudinaria e con un radicale attaccamento alle fonti romanistiche. In questo sistema di fonti molteplici, c’è anche la letteratura (che è una fonte in senso stretto).
Faccio un esempio. Bartolo da Sassoferrato (famoso giurista medievale, appartenente alla scuola dei commentatori) scrive una repetitio (che sostanzialmente è un saggio giuridico) di commento al XII libro del codice di Giustiniano e utilizza, come fonte per articolare il proprio ragionamento giuridico, la canzone di Dante Le dolci rime. Non siamo di fronte a un caso isolato: il fenomeno è talmente diffuso che alcuni storici parlano di dantismo giuridico; movimento i cui maggiori esponenti sarebbero, oltre a Bartolo, anche Alberico da Rosciate e il figlio di Dante, Pietro Alighieri.
Il testo di Bartolo è conosciuto come “trattato sulla dignità”. Bartolo si domanda: la dignità spetta all’uomo per natura o per assegnazione di un potere, o di una carica? Bartolo dichiara di voler riferire le opinioni di un certo poeta volgare di nome Dante Alighieri di Firenze; la fonte romanistica che intende commentare non parla di nobiltà, ma di dignità; nobiltà e dignità sono la stessa cosa, a suo avviso, e questo allora giustifica il ricorso alla canzone di Dante che affronta il tema della nobiltà naturale e teologica. Degno è colui che merita, che ha diritto.
Il concetto di nobiltà (o dignità) indica qualcosa di diverso dal concetto di aristocrazia: l’aristocrazia costituisce il ceto dirigente; si tratta dei nobili che hanno cariche istituzionali. Bartolo definisce nobiltà, in questo senso, proprio la dignità “sine administratione” (ossia senza cariche pubbliche); in questo rifacendosi alla definizione del codice di Giustiniano. La nobiltà o dignità rende un certo soggetto superiore a un altro.
Bartolo afferma che la nobiltà “è ciò che distingue qualcuno da un plebeo”. Si tratta di una categoria che racchiude una serie di etichette, il cui scopo è differenziare qualcuno dalla massa. I giuristi si interrogano su cosa rende eccellente o preminente un uomo rispetto a un altro. Il tema è se si possa essere nobili per natura o se la nobiltà sia la conseguenza dell’intervento di un potere pubblico. Il testo di Dante cerca di definire la nobiltà e propone le principali tesi.
Prima tesi: rende nobile (o degno) il possesso di ricchezze e beni insieme coi bei reggimenti e costumi (“antica possession d’avere con reggimenti belli”). Seconda tesi: gli antichi buoni costumi bastano a rendere l’uomo nobile. Terza tesi: è nobile chi discende da padre o antenato valente. Quarta tesi, che piace a Dante: è nobile chiunque è virtuoso.
Bartolo ricorre a Dante per conferire autorevolezza alla sua Dottrina e al tempo stesso per un obiettivo più generale: affermare che il diritto è una forma di sapienza civile superiore alla letteratura e alla stessa filosofia morale. E difatti conclude che la nobiltà o dignità è quella attribuita per legge e sulla base degli statuti cittadini. La nobiltà naturale e la nobiltà teologica non hanno alcuna influenza sulle gerarchie sociali, al contrario di quella politica e civile. La nobiltà, sostiene Bartolo, è una qualità attribuita da chi detiene il potere politico, che rende manifesto il fatto che qualcuno gode del favore del Principe, innalzandolo al di sopra degli onorati plebei (“onorati”, nell’ottica di Bartolo, perché dotati “di notevole reputazione” anche se non degni, non nobili).
Nel mondo di Bartolo, allora, c’è un coacervo di fonti che confluiscono nel sistema giuridico. Nel mondo di Bartolo, dunque, è difficile maturare la convinzione che il diritto sia espressione di un potere verticale in senso proprio. Questa visione, che è quella a cui siamo maggiormente abituati, difatti, è una delle concezioni teoriche della modernità. E si afferma, gradualmente, a partire dal XIV secolo, proprio dopo la fine del medioevo. Da questa fase storica in poi, il Principe (e poi gli Stati) iniziano a considerare come componente essenziale del proprio potere la produzione di regole. Prima di questa fase storica ”la legge fa il Re”, dopo “Il Re fa le leggi”.
Una visione alternativa, invece, ritiene che il fenomeno giuridico esista quando un gruppo individua condotte che ritiene reciprocamente vincolanti perché funzionali a un obiettivo comune. Questa visione alternativa è espressa dal brocardo “ubi societas, ibi ius”. Gli antropologi aggiungono che il controllo della forza, come strumento reazione, è un passaggio nella creazione del fenomeno giuridico: non c’è bisogno di giungere a un sistema in cui le regolazione è centralizzata. Il controllo e la limitazione della forza si hanno quando, all’interno del ‘noi’ è individuato un attore (un organo, una persona, un gruppo più ristretto) che può intervenire per punire.
In quest’ottica, questo avviene per il diritto romano, secondo alcuni, con le XII Tavole, risalenti al 450 a.C. Qui abbiamo una codificazione della ritorsione privata; e, difatti, non tutti possono punire, ma solo chi ha subito il torto: i familiari agiscono come agenti socialmente autorizzati. Gli storici e gli antropologi del diritto, ritengono che il fenomeno giuridico esista anche in società a “potere diffuso”. E quella del GGG somiglia molto a una società di questo tipo.
Così ragionando, ne abbiamo che: A) esiste il diritto quando le norme sono riconosciute come esistenti dal gruppo, anche se non sono state poste da un organo; B) esiste il diritto anche quando la sanzione è costituita da una vendetta “condizionata”. Ma per quale ragione un gruppo di giganti o di ominidi dovrebbe riconoscere a un certo punto della propria evoluzione una regola come esistente? Per quale ragione a un certo punto, gli ominidi cominciano a rinunciare alla mera e nuda forza? In quanto tale non condizionata e non soggetta a limiti.
Per cercare una risposta, può essere utile raccontare la storia de Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Questo libro narra in forma romanzata e contratta nel tempo quella che verosimilmente è la storia di noi Sapiens: personifica un percorso che è un percorso della specie intera. Nella scala dei tempi geologici il Pleistocene è la prima epoca del periodo Quaternario (che è quello in cui ancora adesso viviamo). Dopo il Pleistocene c’è l’Olocene (che è l’epoca in cui ancora adesso viviamo); prima c’era il Pliocene che è l’ultima poca del periodo Neogene. Il Pleistocene finisce circa con la rivoluzione agricola, intorno ai 10/12.000 anni fa. Prima della rivoluzione agricola se ne compie un’altra fondamentale: circa 70.000 anni fa si compie la rivoluzione cognitiva. Non sappiamo ancora bene per quale ragione, cioè cosa sia accaduta al cervello dei Sapiens, ma questa particolare specie del genere Homo sviluppa capacità differenti dalle diverse specie del genere Homo.
Se potessimo fare una passeggiata nell’Europa di 70.000 anni fa troveremmo sia esemplari appartenenti alla specie dei Sapiens sia esemplari dei Neanderthal. Incontreremmo, dunque, due diversi ominidi simili tra loro ma con caratteristiche di specie diverse. Gli studiosi ritengono che queste due specie si siano imparentate. Nel DNA di noi Sapiens ci sono tracce dei Neanderthal che però come specie autonoma si sono estinti. La rivoluzione cognitiva porta nel giro di qualche migliaio di anni i Sapiens a sviluppare un linguaggio più complesso di quello delle altre specie di Homo perché capace di esprimere un pensiero astratto.
Ricordate l’esperimento iniziale? Due Neanderthal potevano ‘parlare’ (meglio: comunicare) di informazioni concrete relative a fatti presenti: ehi, c’è uno smilodonte che ci vuole mangiare (lo smilodonte è una di quelle tigri con i denti a sciabola). Due Sapiens potevano comunicare informazioni più articolare: ti ricordi quando eravamo al fiume e uno smilodonte tentò di mangiarci? Questa capacità cambia le sorti dei Sapiens perché avere un pensiero astratto e poterlo comunicare agli altri consente loro di proiettarsi al di là del presente e verso il passato (ti ricordi lo smilodonte?); e consente loro di fare altrettanto anche verso il futuro, ipotizzando eventi problematici simili a quelli giù vissuti. Ma soprattutto consente loro di decidere preventivamente quello che avrebbero dovuto fare in futuro e che non avevano fatto in passato.
Il pensiero astratto, e il linguaggio articolato e complesso che consente di esprimere quel pensiero astratto, consentono ai sapiens di organizzarsi per cooperare. Per gran parte di questa storia evolutiva, i Sapiens vivono in gruppi di cacciatori-raccoglitori: la caccia e la raccolta diventano funzioni del gruppo. Questa cosa è a metà tra cultura e natura: non sappiamo cosa sia successo dal punto di vista biologico al cervello dei Sapiens; non conosciamo la scintilla. Sappiamo, però, che questa scintilla produce gradualmente un fenomeno che noi definiremmo culturale; e che questo fenomeno culturale, a sua volta, si imprime nella struttura biologica del nostro cervello.
Il passaggio successivo che a noi interessa è la rivoluzione agricola. La rivoluzione agricola cambia radicalmente gli assetti di questi gruppi di cacciatori-raccoglitori. Non solo e non tanto perché li rende stanziali: alcuni di quei gruppi già lo erano perché cacciavano e raccoglievano più o meno sempre negli stessi posti. Soprattutto perché determina un’espansione demografica che è gestita da un ulteriore salto cognitivo. I cacciatori-raccoglitori si organizzano per cooperare nella caccia e nella raccolta; gli allevatori-coltivatori devono organizzarsi per gestire l’attività agricola che è complessa, caratterizzata dal decorrere del tempo, e proiettata nel futuro.
Più persone, più cose da fare, e la necessità costante di programmare il futuro per evitare di rimanere senza risorse; oltre alla necessità di difendere il gruppo (e i beni del gruppo: ossia i depositi alimentari) da aggressioni esterne. Il pensiero astratto, quindi, aiuta i Sapiens a raccontare cose che li riguardano tutti (le storie sullo smilodonte); questo comporta la nascita di un linguaggio che ha una connotazione narrativa: ossia che serve per condividere le storie del gruppo. E raccontare le storie del gruppo consente di dare ordine, di fissare regole di risolvere i problemi che in passato non erano stati in grado di risolvere. Consente di descrivere fatti allo scopo di prescrivere condotte. L’immaginazione (nella sua accezione di strumento per costruire storie e argomentazioni) supporta l’attitudine a cooperare, e conduce alla definizione di regole organizzative.
Questo percorso si amplifica quando diventiamo allevatori e coltivatori. A questo punto, le narrazioni condivise tendono a riguardare persone che non hanno avuto contatti comuni tra di loro; contatti tanto stretti come quelli dei cacciatori-raccoglitori che vivevano in gruppi più compatti. Il pensiero astratto ci aiuta e fa un salto ulteriore perché l’organizzazione crea non solo regole per svolgere le attività di sostentamento ma anche rappresentazioni comuni che costituiscono il collante tra persone che non si conoscono.
Avete mai sentito un bambino dire “facciamo finta di…”? È una frase tipica dei bambini che esprime quello che siamo biologicamente portati a fare anche da adulti: facciamo finta che questo pezzo di carta valga dieci euro; facciamo finta che una società per azioni possa impegnarsi giuridicamente come fosse una persona fisica; ecc. ecc. Gli scienziati cognitivisti ci descrivono cosa è successo nel nostro cervello. Il nostro cervello ha una sorta di software precaricato che consente di apprendere la lingua del posto in cui siamo nati e che biologicamente è predisposto a imparare qualsiasi lingua (è la tesi Noam Chomsky che ha avuto delle conferme scientifiche). Il nostro cervello è un narratore di storie; il nostro cervello ci racconta quello che siamo, quello che ci accade, ma ci racconta anche quello che potrebbe accadere nella mente degli altri.
Questa cosa si chiama ‘teoria della mente’ ed è quella attitudine che ci consente di entrare in relazione con gli altri (ricordare l’empatia e il romanzo ottocentesco?). Questa cosa (la teoria della mente) ci è servita da un punto di vista evolutivo per cooperare tra di noi: noi siamo la specie in assoluto più cooperativa. Il che non vuol dire che le altre specie non fanno cose insieme: vuol dire che noi abbiamo caratteristiche biologiche (nel cervello ma anche negli occhi e nei corpi) che ci rendono in grado di agire insieme in vista di uno scopo comune rispetto al quale ci percepiamo come un “noi condiviso”.
‘Noi’, allora, non è solo un pericolo ma anche un’attitudine umana. Ma questo “noi condiviso”, frutto di un racconto collettivo e dello scopo di cooperare, non è la stessa cosa del ‘noi’ imposto che ci spersonalizza per renderci eterodiretti verso una felicità “matematicamente impeccabile”. Le due dimensioni del diritto, quella verticale e quella orizzontale, sono percepibili plasticamente nell’opera di un giurista che era anche uno scrittore.
Mi riferisco a Franz Kafka. In questo momento, sentito il suo nome, molti di voi staranno pensando “Beh, sì certo, parleremo del Processo”. Il Processo è uno dei suoi romanzi più famosi e sarebbe uno spunto interessante per “diritto e letteratura”, ma noi parleremo d’altro. Kafka nasce a Praga quando Praga era parte del Regno di Boemia e, dunque, dell’Impero Austro-Ungarico; si laurea in giurisprudenza, dopo aver frequentato per un anno la facoltà di chimica, e lavora per un brevissimo periodo alle Assicurazioni Generali a Trieste; successivamente, per un periodo più lungo presso l’Istituto per gli Infortuni sul lavoro del Regno di Boemia. Lavora presso “l’INAIL Boemo” fino al 1917 e oltre. Andrà in pensione nel 1922 dopo un lungo periodo di malattia (la tubercolosi).
Ci sono tre racconti di interesse per “Diritto e Letteratura”: Davanti alla legge (pubblicato, la prima volta nel 1915); Il nuovo avvocato (nella raccolta Un medico di campagna del 1919); Sul problema delle leggi (pubblicato postumo, come Il Processo). Il Processo esce nel 1925 e contiene Davanti alla legge (Kafka lo recupera e lo inserisce anche come scena interna al romanzo). Secondo alcuni questo racconto sarebbe il nucleo originario del romanzo. Nello stesso periodo, Kafka scrive una serie di relazioni tecniche come funzionario dell’Istituto per gli Infortuni sul lavoro.
Kafka è un funzionario stimato e apprezzato per l’impegno e l’attenzione che mette nell’occuparsi della situazione normativa e delle prassi che riguardano gli infortuni sul lavoro. Il giurista Kafka, dunque, è un giuslavorista ma è anche un narratore. Il giuslavorista Kafka odia un certo modo di intendere il fenomeno giuridico. E questo si ricava sia dal contenuto argomentativo delle relazioni (alcune delle quali estremamente tecniche) sia dalla rappresentazione del sistema giuridico che egli fa nelle opere che abbiamo citato. Questa rappresentazione dipende, ovviamente, dal contesto in cui Kafka opera; ma Kafka non subisce quel contesto alla stregua di uno di suoi personaggi, ossia dall’esterno; Kafka conosce il sistema normativo dall’interno perché Kafka è un giurista: un giurista che si sente a disagio con un certo modo di intendere il diritto.
In Davanti alla legge un contadino giunge dinanzi a una porta dietro la quale sa esserci “la legge”; chiede al guardiano di poter entrare; il guardiano gli dice che potrà entrare, ma non subito. Il contadino sbircia all’interno, vorrebbe convincere il guardiano; ma il guardiano lo mette in guardia e gli dice che se entrerà, a dispetto del suo divieto, troverà per ogni salone un guardiano sempre più potente. A quel punto, il guardiano gli dà uno sgabello e il contadino si siede. Il contadino insiste, cerca di corromperlo. Il guardiano prende tutto ciò che il contadino gli offre, e gli dice: accetto perché non voglio che tu possa pensare di aver trascurato anche solo qualcosa. Ma comunque il divieto rimane. Alla fine della vita, il contadino chiede al guardiano: ma possibile che nessun altro abbia tentato di entrare? E il guardiano risponde: ma questo è il tuo ingresso! Ciascuno ha un proprio ingresso. Adesso che morirai, questo ingresso sarà chiuso.
Vi parlo dell’interpretazione che fa di questo racconto un filosofo del diritto che si chiama Tommaso Greco: la vittima di questo sistema è il guardiano, dice Tommaso Greco. Ha ricevuto un ordine dall’interno; non si fa domande, e non vuole neanche entrare. Qui Greco ci vede la rappresentazione di un tema caro ai filosofi del diritto: l’obbligatorietà delle norme; Kelsen (che è uno dei grandi teorici del diritto del ‘900) pensa che i veri destinatari delle norme siano i funzionari che devono applicare la sanzione. Questa visione verticale e coattiva del diritto è una parte della nostra esperienza ed è una gran parte delle teorie che si sono manifestate dalla nascita delle monarchie assolute in poi (ne abbiamo accennato prima).
Se facciamo il raffronto tra queste rappresentazioni e l’opera concreta del giurista Kafka intravediamo una possibile alternativa a questa concezione del diritto. Nelle relazioni, Kafka si richiama spesso alla negozialità; alla creazione su base volontaria di prassi o di istituti che vadano al di là delle disposizioni che procedono dall’altro. Kafka confronta sempre gli interessi dei soggetti coinvolti nel problema e, dunque, da coinvolgere anche nella soluzione. Nel mondo del lavoro il piano della negoziazione è sempre presente; è presente anche quello della cooperazione tra soggetti e dunque è sempre presente anche una dimensione orizzontale dei rapporti e del fenomeno giuridico.
Il Kafka giurista è un Kafka propositivo: è un Kafka che smuove l’ordinamento; che vuole intervenire nelle prassi e, dunque, direttamente o indirettamente nelle regole. C’è una relazione, tra le molte scritte da Kafka su cui mi vorrei soffermare perché è di interesse per il nostro discorso: quella sulle malattie dei nervi. In questa relazione, Kafka invita a individuare su base cooperativa strumenti per garantire sostegno anche per gli infortuni che non riguardano i corpi ma le menti. Kafka fotografa il momento di passaggio dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; dice: guardate che quello che stiamo vedendo con i reduci di guerra (che tornano malati di nervi a casa) lo abbiamo iniziato a vedere anche prima nelle industrie, quando le macchine hanno iniziato a frammentare la dimensione del lavoro.
La prime automobili sono inventate e messe in produzione da due ingegneri: Daimler e Benz. E la Germania diventerà il volano europeo della seconda rivoluzione industriale. Qui abbiamo due modi diversi di concepire il diritto: la dimensione statica che è sempre verticale (il diritto viene dall’alto ed è inaccessibile: Davanti alla legge) e la dimensione dinamica che è orizzontale e cooperativa (il Kafka giurista). E abbiamo, inoltre, una grande attenzione al mondo del lavoro.
Linguaggio e diritto nascono insieme; e nascono anche per organizzare il lavoro che serve al gruppo (lo abbiamo accennato prima). Il lavoro è sempre stato, storicamente, strumento di inclusione sociale oppure strumento di esclusione e di emarginazione. Pensate solo alla scritta beffarda che accoglie i prigionieri di Auschwitz: il lavoro rende liberi. Non è un caso, dunque, che il lavoro sia il perno della nostra Costituzione.
Il racconto costituzionale
La nostra costituzione inizia proprio così:
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.
La costituzione non solo limita il potere verticale con i diritti di libertà, ma fa qualcosa di più: tenta di spostare l’asse dal noi, al ‘noi condiviso’; ossia a quel noi che non dimentica la dignità del singolo in quanto tale. La costituzione fa tutte queste cose, e le fa in forma narrativa. Ci racconta la società che i costituenti avrebbero voluto. Fa quello che si fa nei romanzi: descrive il contesto di regole in cui si svolgono le nostre vite. E fa questo racconto sia guardando al futuro sia guardando al passato: ci racconta quello che saremo, per contrasto con quello che siamo stati.
Questa idea della costituzione come racconto è un’idea presente in alcuni grandi pensatori del diritto del 1900. Questo racconto collettivo è scritto anche e soprattutto “dalla e nella” dimensione orizzontale del diritto. Non è un racconto del potere ma è un racconto del diritto, ossia di quel sistema cooperativo di cui tutti siamo parte. Nel nostro sistema costituzionale, inoltre, la dignità è un attributo della persona umana in quanto tale, non serve a discriminare gli uni dagli altri; ed è strettamente connessa alla dimensione del lavoro che consente a ciascuno di manifestare pienamente il proprio ‘io’.
Siamo partiti da Gettysburg ma adesso arriviamo a Partinico. Immaginate questa scena. Il mare pieno di barche che vanno a pesca. La spiaggia. Seduti sulla spiaggia tutti i pescatori di Partinico. Ma allora chi sta pescando? Società organizzate che non dovrebbero spingersi così vicino; non dovrebbero pescare in questa parte di mare che è riservata ai pescatori rivieraschi. Eppure, lo fanno. E nessuno interviene.
Poco più in là, un’altra scena. Un gruppo di contadini sta lavorando sulla ‘trazzera vecchia’ per rimetterla in sesto. La trazzera vecchia è una strada impraticabile che rende difficile entrare e uscire da Partinico. Nessuno ha autorizzato i pescatori a morire di fame sulla spiaggia; nessuno ha autorizzato i contadini a lavorare sulla trazzera vecchia. Questa non è una constatazione: questa è l’accusa con cui vengono fermati e processati alcuni giovani intellettuali italiani, tra i quali Danilo Dolci.
Danilo propone ai pescatori di protestare digiunando, ma di farlo in maniera plateale: seduti sulla spiaggia mentre guardano i motopescherecci rubare il loro pesce. Il problema di ordine pubblico non è che stiano digiuni, ma che lo facciano buttando in faccia all’autorità e ai benestanti la loro fame. Questo è considerato sedizioso e inaccettabile.
Altro fatto grave è quello “sciopero alla rovescia”, come verrà definito anche negli atti del processo: lavorare senza incarico e senza retribuzione per sistemare la “trazzera vecchia”. Si tratta di due gesti simbolici di estrema generosità sociale: di solidarietà civica. Siamo nel 1956, la Costituzione è in vigore da quasi dieci anni. Assistiamo, leggendo gli atti del processo, a uno scontro tra due romanzi: il romanzo fascista, quello delle leggi ancora in vigore nel 1956 e che giustificano il processo; e il romanzo costituzionale che è l’incipit di un racconto nuovo.
La storia del suo processo è la storia di un contrasto (che è messo bene in luce da Calamandrei durante l’arringa difensiva) tra il mondo fascista e liberale (nel senso ottocentesco del termine) – che resiste, se non negli assetti istituzionali quantomeno nella mentalità – e il mondo che i nostri costituenti hanno scritto per noi. Quando vi dicevo dell’immaginazione come parte del diritto e come capacità di raccontare il mondo che si vile per il futuro, mi riferivo proprio a questo. Le costituzioni, ovviamente anche la nostra, sono scritte proprio come racconti in antitesi con il mondo che è stato.
Pensate alla dimensione del lavoro e alla contrapposizione con la proprietà che è il tratto tipico delle società divise in ordine (come l’àncien regime) o comunque basate sul censo come la società borghese ottocentesca. La dimensione epocale di questo contrasto è evidenziata dall’arringa di Calamandrei. Calamandrei parte da un’obiezione mossa dal pubblico ministero. Il PM sostiene che una cosa sono le leggi dello stato, altra le “correnti di pensiero” di cui s’è parlato in aula a difesa degli imputati. Le “correnti di pensiero” sarebbero i valori costituzionali. Questa distinzione riecheggia la doppia dimensione con cui ci siamo confrontati finora: quella verticale del potere, e quella orizzontale del diritto; diritto che non può fare a meno della dimensione valoriale. E Calamandrei risponde: e cosa sono le stesse leggi se non “correnti di pensiero”? Le leggi sono vive “perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, mettervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il nostro pianto”.
Poi, continua dicendo “il nostro tempo ha carattere eccezionale e conturbante”. È un tempo di trasformazione e di grandi promesse: “cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del popolo nelle sue leggi: che il popolo senta le leggi dello Stato come le sue leggi, come scaturite dalla sua coscienza, non come imposte dall’alto. Affinché la legalità discenda dai codici nel costume, bisogna che le leggi vengano dal di dentro non dai di fuori”.
Ci siamo chiesti all’inizio perché mai Zamjatin abbia rappresentato un sistema sociale che odia l’immaginazione. Un’avversione simile nei confronti delle emozioni e della fantasia la ritroviamo in un autore lontanissimo per esperienze, per cultura e per obiettivi polemici: mi riferisco a Dickens. E penso all’incipit di Tempi difficili. Dickens ci racconta l’800 borghese e la società del carbone: siamo nella prima rivoluzione industriale, agli inizi della società borghese e capitalista.
L’incipit di Tempi difficili è ambientato in una scuola. Il protagonista di questa scena si descrive come un uomo “eminentemente pratico” che odia le fantasticherie. Nella società di Tempi difficili non c’è spazio per i divertimenti, per i giochi, per il circo, per le smancerie; solo ciò che si può toccare, che ha una dimensione pratica, che è oggettivo: solo questo conta. Siamo di fronte a due rappresentazioni sarcastiche di modelli sociali che mettono al bando l’immaginazione; modelli di società in cui tutto dev’essere “matematicamente impeccabile” oppure “eminentemente pratico”. Perché? Mi sembra che la risposta stia nel percorso che abbiamo compiuto oggi: l’immaginazione è una facoltà essenzialmente umana; è la facoltà tipica dell’altro polo rappresentato dal titolo: è la facoltà dell’io. E il noi, quando diventa ipertrofico, mal sopporta l’io e, dunque, mal sopporta l’immaginazione che è la facoltà che lo contraddistingue più delle altre.
Abbiamo parlato di letteratura, diritto e lavoro. Come dicevamo all’inizio: questa è la definizione ostensiva di Diritto e Letteratura che volevo darvi. Quello che abbiamo fatto finora è Diritto e Letteratura. Abbiamo visto che la nostra democrazia è fondata sul lavoro e che il lavoro ci consente di esprimere ciò che siamo.
Voglio chiudere con un augurio per voi.
La radice latina di “lavoro” indica la fatica: in alcune lingue e in alcuni dialetti per indicare il lavoro si usa il termine fatica o travaglio. Nella radice sanscrita, invece, il significato è diverso. Lavoro è “conseguire ciò che si desidera”. La democrazia, in fondo, dovrebbe essere proprio questo: non lo strumento per conquistare una felicità matematicamente impeccabile ma lo strumento che consente a ciascuno di conseguire ciò che desidera. Il mio augurio per voi è che in futuro possiate affermare, parafrasando il discorso di Pericle: noi in Italia facciamo così, conseguiamo ciò che desideriamo.
Bibliografia (minima) ragionata
1. Il divieto di pensare all’elefante rosa richiama un esperimento, ormai classico nella psicologia, condotto per la prima volta da Daniel Wegner e David Schneider nel 1987; l’effetto paradossale che ne deriva (cioè il pensiero ossessivamente puntato sull’immagine vietata) è definito ‘processo ironico’. L’esperimento ricorda un passaggio scritto da Dostoevskij in Note invernali su impressioni estive: “Provate a darvi questo compito: di non ricordarvi dell’orso bianco, e vedrete che lui, il maledetto, vi tornerà in mente ogni minuto”.
2. Gli enunciati come “lo giuro” sono definiti enunciati performativi; sulla natura del giuramento quale atto performativo: Emile Benveniste, Vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi.
3. Sul tema “parole che fanno cose”: John L. Austin, Come fare cose con le parole, Marietti; John R. Searl, Atti linguistici, Bollati-Boringhieri.
4. Su “Diritto e Letteratura”: Gary Minda, Teorie postmoderne del diritto, Il Mulino; Brian H. Bix, Teoria del diritto. Idee e contesti, Giappichelli (edizione italiana a cura di Andrea Porciello); Riccardo Gualdo e Raffaella Petrilli (a cura di), Diritto, linguaggio e letteratura, Guerra edizioni; Arianna Sansone, Diritto e Letteratura, Giuffrè; Uberto Scarpelli e Paolo Di Lucia (a cura di), Il linguaggio del diritto, LED; Michele Marchesello e Roberto Negro (a cura di), Il diritto allo specchio della letteratura: materiali di lettura per giuristi e non, De Ferrari.
5. Sulle definizioni, non solo ostensive: Irving M. Copi e Carl Cohen, Introduzione alla logica, Il Mulino.
6. Sulla storia e sulle tecniche della retorica: Bice Mortara Garavelli, Manuale di Retorica, Bompiani; Maria Pia Ellero, Retorica. Guida all’argomentazione e alle figure del discorso, Carocci.
7. Sui discorsi giuridici, quali discorsi argomentativi e sul rapporto tra logica e diritto: Gaetano Carcaterra, Presupposti e strumenti della scienza giuridica, Giappichelli; Francesco Cavalla (a cura di), Retorica processo verità. Princìpi di filosofia forense, FrancoAngeli.
8. Sulla democrazia ateniese, in particolare come democrazia aperta ai non possidenti: Gustavo Zagrebelsky, Fondata sul lavoro, Einaudi; Ellen Meiksins Wood, Contadini-Cittadini & Schiavi. La nascita della democrazia ateniese, Il Saggiatore; Luciano Canfora, La democrazia di Pericle, Laterza.
9. Sulla figura di Lincoln: James M. McPherson: La guerra di Lincoln, 21 Editore.
10. Il discorso di Gettysburg è reperibile su internet a questo link: https://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_di_Gettysburg#Testo_del_discorso_di_Gettysburg
11. Sulla distinzione tra argomentazione e dimostrazione, oltre al citato testo di Copi e Cohen: Giovanni Boniolo e Paolo Vidali, Strumenti per ragionare, Pearson.
12. Sulla creatività come strumento del giurista: Giovanni Pascuzzi, La creatività del giurista. Tecniche e strategia dell’innovazione giuridica, Zannichelli.
13. Sulle società a potere diffuso: Rodolfo Sacco, Antropologia giuridica, Il Mulino.
14. Sul rapporto tra principio di sovranità popolare, costituzionalismo e Stato di diritto: Corrado Caruso e Chiara Valentini (a cura di), Grammatica del costituzionalismo, il Mulino; Stefano Petrucciani, Democrazia, Einaudi.
15. Sulla storia dei diritti umani, anche in rapporto all’evoluzione del romanzo moderno: Lynn Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, Laterza; Marcello Flores, Storia dei diritti umani, il Mulino; Nicola Casaburi, Il cammino della dignità, Ediesse; Emanuele Felice, La conquista dei diritti, il Mulino.
16. Sulla dimensione orizzontale e cooperativa del diritto: Tommaso Greco, La legge della fiducia, Laterza; Sergio Cotta, Perché il diritto, ELS; idem, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè.
17. Sul diritto a Roma: Eva Cantarella, Diritto romano, Istituzioni e storia, Mondadori; Mario Bretone e Mario Talamanca, Il diritto in Grecia e a Roma, Laterza; Aldo Schiavone, Ius: L’invenzione del diritto in occidente, Einaudi.
18. Sul dantismo giuridico: Justin Steinberg, Dante e i confini del diritto, Viella; Claudia Di Fonzo, Dante e la tradizione giuridica, Carocci.
19. Sulla natura cooperativa del pensiero umano, sulla rivoluzione cognitiva e sul funzionamento del cervello: Michael Tomasello, Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli, Bollati Boringhieri; idem, Unicamente umano. Storia naturale del pensiero, il Mulino; Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi, Bompiani; Antonio R. Damasio, Sentire e conoscere, Adelphi; Lisa Feldman Barret, 7 lezioni e ½ sul cervello, il Saggiatore; Will Storr, La scienza dello storytelling: Come le storie incantano il cervello, Codice edizioni.
20. Sull’evoluzione del lavoro: Germano Maifreda, L’organizzazione del lavoro. Dalla rivoluzione industriale allo smart working, Pearson; James Suzman, Lavoro: Una storia culturale e sociale, il Saggiatore; Ricardo Antunes, Addio al lavoro, Edizioni Ca’Foscari; Stefano Massini, Lavoro, il Mulino.
21. Sul diritto come inventio e come racconto: Paolo Grossi, L’invenzione del diritto, Laterza; Jerome Bruner, La fabbrica delle storie, Laterza; Flora Di Donato, La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel ‘processo’, FrancoAngeli; Ronadl Dworkin, La giustizia in toga, Laterza.
22. Sul processo a Danilo Dolci: Danilo Dolci, Processo all’art. 4, Sellerio.
23. Sul lavoro nella Costituzione italiana: Cesare Pinelli, Lavoro e costituzione, Editoriale Scientifica; Mariuccia Salvati, Art. 4, Carocci.
24. Le relazioni di Kafka sono pubblicate da Einaudi.
25. Il processo a Paolo Orgiano è pubblicato da Viella, a cura di Claudio Povolo.